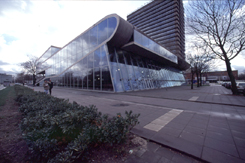Il progetto
Il progetto dell’Educatorium segna, nel 1993, la prima fase dei
lavori di modernizzazione e urbanizzazione del Campus universitario
di Utrecht, lo ‘Uithof’.
L’edificio è stato progettato per essere usufruito come struttura
condivisa dalla comunità universitaria e dai vari istituti di ricerca
dell’ateneo.
L’intervento congiunge due edifici degli anni Sessanta, già esistenti
all’interno Campus, con una innovativa architettura ibrida di vetro
e acciaio, sezionata da un nastro di cemento che asseconda la sua
forma in funzione dei percorsi e dei diversi spazi funzionali.
Il nome dell’intervento è stato appositamente coniato per alludere
a una “fabbrica dell’apprendimento”: la struttura, infatti, oltre
a configurarsi come perno del Campus (costituito da un organico che
conta circa trentamila persone), è pensata per ospitare seminari
e conferenze di carattere regionale e internazionale.
L'edificio, che si estende su 11.000 mq, ospita due sale conferenze
(rispettivamente per 400 e 500 persone), tre aule in cui svolgere
gli esami, alcune sale di studio e una caffetteria, con annessa mensa,
per circa mille persone.
Il progetto si basa su una ricerca formale del tutto innovativa:
due ‘fogli’, rispettivamente di calcestruzzo e di vetro, si piegano
e si fondono per aderire alle esigenze del programma. Il primo è
morbido, malleabile, dinamico, l’altro è solido, rettangolare, passivo.
Koolhass in questo intervento segue uno specifico programma anche
dal punto di vista strutturale: il progetto persegue infatti l’obiettivo
di ridurre al minimo l'utilizzo dei materiali. La scelta di adoperare
una struttura mista acciaio-cls permette di usare al massimo
le proprietà di entrambi. Gli elementi strutturali in cemento hanno,
ad esempio, uno spessore di soli 20 cm.
L’organizzazione planimetrica si basa sull’intersezione di due grandi
corridoi che funzionano come percorsi principali di collegamento.
A partire da essi si distribuiscono tutti i momenti della vita studentesca:
gli incontri informali al bar, l’apprendimento e lo scambio culturale
negli auditorium e nelle aule, i rituali quotidiani di percorso verso
le aule per svolgere gli esami.
Lo spazio dell’intero complesso è frammentato, a sua volta, in una
serie di ambienti più piccoli, non troppo caratterizzati dal punto
di vista funzionale, in modo da creare dei punti di attrazione autonomi
che assecondano il movimento e lo scambio delle funzioni e degli
studenti.
I due elementi architettonici più caratterizzanti del programma sono
rappresentati dall’auditorium e la caffetteria. Al primo si accede
attraverso un’ampia rampa delimitata due pareti curve rispettivamente
in muratura e in vetro; è orientato verso un giardino botanico a
nord, come fosse un anfiteatro collocato nel paesaggio.
Sotto il piano inclinato dell’auditorium è situata la caffetteria
progettata per ospitare fino a mille persone. Lo spazio è stato pensato
come un unico ambiente suddiviso in una successione di ‘piazze’ interne
abbozzate da colonne portanti che, con la loro disposizione irregolare,
generano un paesaggio alberato artificiale.
La tecnologia costruttiva
Per soddisfare l’obiettivo di massima apertura verso l’esterno, la
facciata inclinata del ristorante dell’Educatorium ha richiesto pannelli
di vetro di dimensioni considerevoli. La superficie vetrata ha infatti
una altezza variabile dai 3,5 agli 8 metri. Per consentire una visuale
il più possibile libera verso l’esterno, allo stesso tempo, si è
dovuto a ridurre le dimensioni dei montanti della facciata.
Per assorbire le sollecitazioni prodotte dall’azione del vento è stato necessario
aggiungere delle pinne in vetro con funzione di controventamento. Nella facciata
ovest queste sono poste all’esterno mentre in quella rivolta a nord sono posizionate
verso l’interno.
Un problema non trascurabile si è però presentato in corrispondenza delle sezioni
in cui la facciata si sviluppa con altezza massima. L’impossibilità, in quel
momento, di ottenere lastre di vetro temprato di lunghezza superiore ai 4,50
metri ha reso inevitabile la scomposizione dell’elemento controventante vetrato
in componenti di dimensioni minori e la loro successiva connessione meccanica
tramite piastre. Inoltre, per non creare un punto strutturalmente debole, si
è dovuto progettare il giunto a intervalli di 2-4-2 metri, facendo particolare
attenzione a non collocarlo propro in corrispondenza della metà della campata.
Le pinne in vetro sono state integrate all’interno dei montanti in alluminio;
hanno una larghezza 400 mm e sono posizionate a una distanza, l’una dall’atra,
di circa 2 metri. I singoli elementi vetrati che compongono una pinna di controventamento
sono ammorsati per mezzo di due piastre imbullonate in acciaio.
Precedentemente abbiamo accennato a come il concept dell’Educatorium si basi
su diagrammi stabiliti dai percorsi e su come questi flussi fungano da direttrice
per la modellazione delle superfici in calcestruzzo mentre quelle vetrate ne
rimangono esenti.
L’unica superficie vetrata che viene coinvolta in questa dinamica è quella che
delimita l’auditorium principale.
Lo spazio della sala conferenze è infatti chiuso da una doppia parete curva vetrata.
Ogni pannello in vetro è sorretto da un sistema di fissaggio puntuale sostenuto
da un tubo in acciaio di 46 mm di diametro. Per contrastare i carichi orizzontali
i due tubi, posti a una distanza di circa 300 mm l’uno dall’altro, sono connessi
sul piano orizzontale tramite delle apposite barre in vetro del diametro di 30
mm in modo da formare un struttura irrigidente “a scala”. Tutta struttura è a
sua volta appesa al soffitto in modo da non essere soggetta alle oscillazioni
del piano di calpestio dovute alla circolazione delle persone. I connettori orizzontali
sono vetrati per concorrere a rendere la struttura di questo muro il più possibile
impercettibile.
Gli architetti hanno sviluppato la concezione strutturale della parete vetrata
prendendo a riferimento il muro del Kempinski Hotel dell’aeroporto di Monaco
di Helmut Jahn e Jörg Schlaich; questo sistema è costituito da pannelli vetrati
connessi a una tensostruttura posta in trazione dal soffitto al pavimento. Koolhaas
ne ha rielaborato il principio strutturale e ha inoltre raddoppiato la parete
vetrata per aumentare l’isolamento sonoro in modo da proteggere la sala lettura
dai rumori provenienti dal passaggio delle persone attraverso il corridoio esterno.
In corrispondenza di curvature, il dettaglio è stato risolto tramite una sovrapposizione
di pannelli di vetro, in similitudine con le scaglie di un pesce. In corrispondenza
di questo nodo, per incrementare le prestazioni di isolamento sonoro della parete
è stato indispensabile l’uso di silicone. Un impiego non indifferente di silicone
si è reso necessario anche in corrispondenza dell’innesto della barra di vetro
con il tirante in acciaio, facendo perdere alla parete vetrata un po’ della sua
trasperenza.
Il materiale
Per realizzare l’involucro vetrato della mensa sono state adoperate
ampie superfici vetrate isolanti: in questo progetto l’utilizzo di
tale tipo di vetro è stato funzionale alla riduzione delle dispersioni
termiche e dei consumi energetici. L’inclinazione della facciata
Ovest inoltre, assicurando un'incidenza ottimale dei raggi solari,
consente l'accumulo di calore per effetto serra e il risparmio di
energia elettrica per l'illuminazione.
I pannelli vetrati isolanti usati per la facciata della mensa hanno dimensioni
massime di 1,8 x 6 metri; consistono in un vetrocamera con lastra interna
di vetro stratificato 6 + 6 mm con camera d’aria di 10 mm e lastra esterna di
vetro temprato di 10 mm.
Le pinne di controventamento hanno lo spessore di 15 centimetri e sono costituite
da vetro temprato in modo da permettere la foratura per il collegamento alle
piastre in acciaio. Tra il vetro e la piastra è presente una guarnizione in neoprene.
Il “muro” curvo di vetro che racchiude l’auditorium, che varia in altezza da
8 a 2,5 metri, non ha solo funzione di elemento di separazione spaziale
ma anche di isolamento acustico, motivo per cui è costituito da una doppio strato
vetrato. I pannelli sono costituiti da vetro temprato dello spessore di 8 mm
e hanno ognuno forma quadrata di 1,2 x 1,2 metri.
Gli ambienti dell’auditorium sono rivolti a nord verso il parco: il fatto di
aver adottato grandi superfici vetrate non rappresenta comunque un’insidia dal
momento che non sussiste il problema del surriscaldamento dovuto all’azione del
sole.
Le sale dell’auditorium necessitavano però di una parete di divisione schermante
in modo da incentivare la concentrazione e non distogliere l’attenzione degli
studenti dallo scenario esterno. La necessità di schermatura per le proiezioni
richiedeva quindi un muro opaco.
Tra le varie soluzioni proposte era stata valutata l’idea di porre, come elemento
separatore, una vetrata traslucida con tende poste a sistema di schermatura.
Dal momento che questa proposta non si era rivelata soddisfacente si è deciso
di trattare la parete con una pellicola olografica che cambia dal traslucido
al trasparente secondo la posizione di chi guarda; in questo modo la parete di
vetro agisce come una nuvola artificiale che consente alternativamente la vista
verso l’esterno, fornendo al tempo stesso prestazioni di controllo solare.
Si è deciso quindi di utilizzare un nuovo tipo di vetro, denominato “Lumisty”
prodotto dalla giapponese Asahi Glass. Questo vetro innovativo ha la proprietà
di essere completamente trasparente come il vetro tradizionale, quando lo si
guarda in direzione perpendicolare, ma traslucido e grigiastro quando viene osservato da
una diversa angolatura. Questa qualità è conferita da un film olografico, incollato
invisibilmente sulla superficie della lastra di vetro. Il tipo di trattamento
adoperato sul vetro ha risposto in maniera ottimale
alla soluzione che stava cercando l’architetto: una visuale limitata ma che,
al contempo, desse la possibilità di creare un diversivo per gli studenti aprendo
una piccola finestra verso il parco, permettendo che il passaggio esterno non
dia fastidio a chi si trova all’interno.
La parete così trattata si pone inoltre
in contrapposizione con la trasparenza offerta dalla facciata posta a separare
la mensa dall’esterno.
L’edificio è di considerevole importanza anche sotto l’aspetto inerente alla
riduzione dei consumi energetici: il controllo dell'illuminazione naturale e
del sistema di riscaldamento-raffreddamento ha fornito agli spazi interni condizioni
visive e termiche ottimali.
Riferimenti bibliografici
- Rob Nijsse, Glass in structures: elements,
concepts, design, Birkhauser, Basel, 2003.
- Rocca Alessandro, Educatorium a Utrecht,Rem Koolhaas, Alinea, Firenze,
1999
- OMA, “Educatorium en Utrecht” in El Croquis n° 88-89, 1998, pp. p. 64–107
- Rem Koolhass, “Un despilegue tectonico” in Arquitectura Viva, n. 57,
1997, pp. 62 - 70
- OMA, “Educatorium Utrech, Olanda” in Domus, n° 800, 1998, pp. 42-47
Disegni
Sezione
orizzontale partizione interna
Sezione
verticale facciata ovest
Sezione verticale partizione interna_1
Sezione
verticale partizione interna_2
Struttura parete doppia
Credit
Disegni elaborati da Elisabetta Carattin sulla base della documentazione
contenuta in El Croquis n. 88-89, 1998, pp. 64-107 |