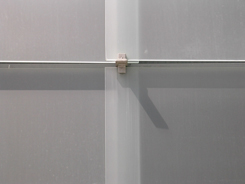Il progetto
Nel 1993 la cittadina austriaca di Bregenz indice un concorso d’idee per la costruzione
di un nuovo museo dell’arte davanti al Lago Costanza. L’isolato su cui doveva
sorgere la nuova architettura ha un carattere particolare: l’impianto del
sito è caratterizzato da un preesistente braccio di edifici isolati che sono
proceduti verso il lago attraverso delicati interventi puntuali che però,
nel tempo, non hanno però creato un margine definito. Caratteristica specifica
del bando del concorso era quindi la definizione di un nuovo intervento architettonico
che si inserisse nella cortina edilizia lungo la riva come un elemento tanto
autonomo quanto consapevole. Un altro paradigma progettuale fondamentale
richiesto dal bando era la caratterizzazione di questa nuova architettura
per mezzo della luce.
Sulla base di questi i presupposti il progetto di Zumthor, rispetto agli altri
partecipanti, mostrava due caratteristiche essenziali che ne hanno decretato
il successo. Il progetto presentato dall’architetto svizzero è riuscito a interpretare
in maniera originale il tema della luce e a inserirsi con naturalezza nel panorama
di Bregenz nonostante la decisa caratterizzazione del propria immagine.
Il Museo è stato concepito come una costruzione solitaria in una locazione prominente
ma non troppo distante dallo specchio d’acqua del lago. L’edificio espositivo,
osservato dall’esterno, appare come una sorta di “faro”, una fonte di luce
all’interno della città.
L’intervento di Zumthor è costituito da una torre isolata di vetro che nasconde
in realtà una struttura di calcestruzzo che fornisce la composizione spaziale
interna dell’edificio.
L’edificio attraverso la stratificazione del suo involucro, costituito da superfici
riflettenti sovrapposte, assorbe al suo interno la luce, la riflette e
dà indicazione della sua vita interna a seconda dei differenti angoli di visione.
Il museo si sviluppa su quattro piani fuori terra e due interrati, concentrando
al suo interno la funzione primaria espositiva. Tutti i servizi accessori come
la libreria, i negozi, il caffè e gli uffici sono situati in un secondo edificio,
che con la sua a attacco separata dà origine una nuova piazza. L’ingresso al
Museo, che avviene dalla piazza antistante, si trova sul lato est dell’edificio,
è fuori asse ed è rivolto verso la città. Oltrepassata l’entrata il visitatore
giunge in un ambiente multifunzionale racchiuso da pareti portanti in cls che
delimitano un quadrato interno, vera superficie espositiva. Posteriormente a
questi elementi strutturali sono collocati tutti gli elementi di servizio e di
distribuzione.
A causa della ridotta dimensione del sito si è dovuto rinunciare alla classica
organizzazione lineare di sale a illuminazione zenitale. Il principio del percorso
continuo è qui salvaguardato tramite l’espediente della sovrapposizione
delle sale espositive. Questo principio distributivo a concatenazione verticale,
assecondato dalla disposizione delle piattaforme strutturali che si accompagnano
a un leggero movimento rotatorio, genera un itinerario di visita spiroidale.
Il principio dell’attraversamento degli spazi avviene non assialmente ma tangenzialmente:
in questo modo si può cogliere ogni sala con un solo colpo d’occhio.
Il primo livello interrato è anche esso accessibile al pubblico: ospita una sala
lettura, il centro educativo del museo, un magazzino e vari impianti di servizio.
Al suo interno è possibile godere di condizioni di luce naturale che giunge
a diffondersi nell’ambiente attraverso l’intercapedine di 90 centimetri dell’involucro
vetrato.
Il secondo livello interrato, che non è invece accessibile al pubblico, ospita
l’archivio originale, dei laboratori e i locali per gli impianti.
Per quanto concerne i livelli superiori, i restanti tre piani per le esposizioni
si distinguono tra loro solo per le differenti quote dei soffitti. Quello che
in un museo è in relazione alla differenziazione dimensionale delle sale o della
direttrice di visita, qui si manifesta per mezzo del trattamento delle pareti
e nell’altezza delle sale. Il terzo e ultimo piano, che è quello che può godere
delle condizioni migliori di illuminazione, è infatti alto 4,70 metri mentre
il primo e il secondo misurano 4,20 metri.
La tecnologia costruttiva
Il design strutturale del museo si dichiara già nel progetto del
foyer del piano terra.
Lo spazio interno è infatti strutturato in area espositiva e di servizio
per mezzo di tre setti portanti che sorreggono i piani e il soffitto
della Kunsthaus. Le partizioni interne, oltre a caratterizzare la
pianta dell’edificio, qui svolgono anche funzione strutturale: sono
costituite da tre lastre verticali, che si sviluppano attraverso
l’intero edificio, in calcestruzzo armato a vista realizzate con
un unico getto, dello spessore di 72 cm.
Tutte le unità funzionali (vani scale, uscite di sicurezza, ascensori
e montacarichi) e gli elementi tecnici sono nascoste dietro a esse
in modo da dare origine uno spazio espositivo a pianta libera di
464 m2 per piano.
Gli elementi del nucleo portante hanno inoltre la funzione di provvedere
alla climatizzazione dell’edificio: i solai e i setti strutturali
sono infatti attraversati da un sistema di tubature collegate e delle
pompe geotermiche che, in cooperazione con il sistema di facciata
e con un sistema di canali di aerazione interno ai solai, riducono
ulteriormente il dispendio energetico per la climatizzazione. Vale
la pena ricordare che la Kunsthaus è stato il primo museo a essere
costruito senza fare ricorso a un sistema di condizionamento dell’aria
tradizionale per rispondere ai requisiti delle opere esposte.
I solai, che appoggiano sui setti, sono in lastre pretese di calcestruzzo
dello spessore di 80 cm; presentano inoltre, in corrispondenza dello
sbalzo terminale, un profilo smussato che permette alla luce di penetrare
più in profondità.
Le superfici dei singoli ambienti sono inoltre caratterizzate da
diversi trattamenti cromatici e di posa; il pavimento è costituito
da Terrazzo di colore grigio scuro privo di giunti al piano terra
mentre le scale e i piani superiori sono in una tonalità di grigio
più chiara. Il soffitto del piano terra, senza rivestimenti, rimane
in cemento a vista, con l’unica eccezione delle lampade semisferiche
per l’illuminazione artificiale.
L’involucro esterno dell’edificio è costituito da una doppia pelle
vetrata.
La facciata è stata progettata per essere una struttura autoportante,
completamente indipendente dall’edificio. Ridotta all’essenziale
in termini statici, è ancorata all’edificio solo per scaricare i
carichi dovuti al vento: “i dettagli hanno il compito di esprimere
ciò che l’idea progettuale di fondo esige in quel determinato punto
dell’oggetto: unione o disgiunzione, tensione o leggerezza, attrito,
solidità, fragilità … i dettagli, quando riescono felicemente, non
sono una decorazione. Non distraggono, non intrattengono ma inducono
alla comprensione del tutto, alla cui essenza necessariamente appartengono
”1
La struttura spaziale della facciata in acciaio, del peso totale
180 tonnellate, è composta da un telaio in elementi prefabbricati
in acciaio lunghi 27 metri, con una campata strutturale di 4,5 metri
e con una profondità di 0,9 metri.
Questi sorreggono i due strati del rivestimento costituiti da lastre
vetrate in vetro stratificato con trattamento superficiale di acidatura
all’esterno e da vetrocamera all’interno.
Le lastre della pelle esterna di vetro sono tutte della stessa dimensione.
Non sono né perforate né tagliate; appoggiano su staffe e sono trattenute
da graffe in acciaio cromato munite di guarnizioni di protezione.
I giunti delle lastre di vetro rimangono aperti, lasciando esposti
gli angoli delle scandole che in questo modo rimandano a una pelle
squamata.
La sagomatura delle graffe permette l’aggancio di quattro lastre
contemporaneamente, due sulla parte superiore e due in quella inferiore,
mantenendo ognuna delle scandole orientata secondo la direttrice
stabilita e separata dalle altre per consentire il passaggio dell’aria.
In corrispondenza dei punti in cui le graffe supportano il peso della
lastra si notano delle spesse sigillature in silicone che sono stati
applicate in stabilimento. Questo collegamento adesivo ha richiesto
di speciali riguardi durante la produzione dal momento che costituisce
una connessione che deve supportare tutto il peso della lastra nel
momento in cui questa si rompe.
In corrispondenza dell’attacco con il suolo le graffe sono innestate
direttamente nel pavimento asfaltato della strada attraverso delle
viti e fanno in modo che le scandole sfiorino appena il terreno.
Le due pelli del rivestimento sono separate da una intercapedine
di 90 centimetri di spessore che penetra, in sezione, fino al primo
livello interrato rendendo possibile il raggiungimento della luce
naturale fino a questo piano sotterraneo.
Il sistema di aggancio è importante anche dal punto di vista architettonico
in quanto le sporgenze che si vengono a creare rendono la facciata
una parete vibrante anche se regolata da una rigida modularità.
L’aria del lago penetra all’interno dell’intercapedine tra il vetrocamera
e le lamelle esterne e crea un sistema di raffrescamento passivo
per mezzo del moto convettivo che ha origine al suo interno. Questa
cavità è inoltre attrezzata con ascensori per i servizi e il mantenimento
dell’edificio e con un sistema di punti luce per illuminare il museo
nelle ore notturne. Oltre a ciò è collocato un sistema di oscuramento
flessibile costituito da lamelle mobili per la protezione solare
e la modulazione della luce interna, regolato automaticamente in
funzione della radiazione solare da un sensore della luce disposto
sulla copertura.
Vista la peculiarità dell’intervento, la costruzione della vetrata
ha richiesto notevoli sforzi di progetto di installazione al
costruttore. Per quanto riguarda l’assemblaggio della facciata interna
il primo problema che si è verificato ha riguardato l’installazione
del vetrocamera che non si è potuta verificare né dall’interno, a
causa della dimensione maggiore del modulo rispetto all’effettiva
apertura da vetrare, né tantomeno dall’esterno perché la struttura
portante in acciaio ne impediva l’accesso.
L’unica possibilità era quella di far scivolare all’interno dell’intercapedine
le lastre verso il basso a partire dalla copertura.
Per questo progetto il sistema di assemblaggio è stato sviluppato
appositamente dall’azienda Glas Marte.
Sul tetto, a una altezza di 32 metri, è stata posta una gru mobile
e scorrevole su rotaia in grado di sollevare, mediante ventose
applicate a una intelaiatura di sostegno, gli elementi vetrati direttamente
dal container con cui venivano trasportati e collocati nella posizione
in cui si sarebbero dovuti calare.
Durante le delicate operazioni di assemblaggio del vetro si è dovuto
tener conto di una tolleranza di soli 16 millimetri dovuta alle protuberanze
meccaniche degli elementi di fissaggio della struttura del rivestimento.
Per precauzione, a causa dell’estrema delicatezza del materiale,
prima dell’assemblaggio di qualsiasi lastra vetrata è stato preventivamente
usato un tester di legno con dei sensori elettrici per verificare
la presenza di eventuali elementi di disturbo che si sarebbero potuti
incontrare durante l’installazione.
1_Peter Zumthor, Pensare architettura, Electa, Milano, 1998,
pg 12.
Il materiale
La sovrapposizione dei piani espositivi, profondi e di forma quadrata,
dovuta ai motivi di spazio prima esposti, richiedeva una concezione
della luce innovativa, che nella fase concorsuale era stata solo
abbozzata.
La Kunsthaus è stata concepita come un museo in grado di impiegare
la luce naturale. All’interno delle sale espositive hanno origine
solo zone a illuminazione differente ma nessuna ombra.
La facciata, costituita da lastre di vetro acidato, funge da filtro
per la diffusione della luce che la attraversa, illuminando gli ambienti
interni in maniera differente a seconda dell’ora del giorno e del
periodo dell’anno. In questo modo si crea un’atmosfera luminosa naturale
anche in assenza di aperture visibili e il visitatore può notare
infatti come Zumthor gli impedisca ogni visuale verso l’esterno in
modo da catalizzare la sua concentrazione esclusivamente sull’arte
e sugli spazi espositivi.
Per la facciata sono state impiegate lastre di vetro acidato che
rappresentano l’elemento più importante del programma di illuminazione
dell’edificio. Tutte le lastre esterne hanno la possibilità di essere
facilmente pulite e sostituite; inoltre, grazie al loro lungo ciclo
di vita, si possono disassemblare e riutilizzare.
La luce, attraverso questo materiale, viene rifratta per tre volte:
prima per mezzo della pelle esterna squamata, poi tramite la vetrata
isolante fino a fondersi con quella del controsoffitto vetrato.
La pelle più esterna è costituita da 712 scandole di vetro stratificato
costituito da lastre di vetro float extra-chiaro unite da uno strato
intermedio quadruplo di PVB, che presentano un trattamento
di acidatura sul lato esterno della lastra. Ogni lastra pesa 252
kg e ha la dimensione di 1,72 x 2,93 m.
La vetrata interna è costituita da un vetrocamera anch’esso acidato
composto da una lastra interna in vetro stratificato (doppia lastra
di vetro float extra - chiaro), una camera d’aria di 12 mm con all’interno
gas krypton e una lastra esterna di vetro float da 6 mm. L’area totale
di vetrocamera è di 2000 m2; le unità di dimensioni maggiori misurano
1,42 x 4 metri, con un peso di 255 kg.
Le partizioni verticali interne dei piani interrati sono costituite
di vetrocemento, sia per il pavimento che per il controsoffitto.
I soffitti dei piani successivi al livello di entrata contribuiscono
anche essi, insieme a tutto il sistema, alla definizione di un rapporto
della luce ambientale prossimo alle condizioni naturali. Le lastre
della controssoffittatura sono costituite da un vetrocamera composto
da vetro float extra-chiaro con doppio strato di PVB da 0,375 mm,
una camera d’aria di 12 mm con gas argon e una lastra esterna di
6 mm in vetro float extra chiaro acidato sul lato inferiore.
Il sistema di controssoffittatura è costituito da 705 elementi quadrati
(235 per piano), delle dimensioni di 1,45 x 1,45 m, del peso di 63
kg ciascuno, sospesi da giunti ben visibili sorretti da aste in acciaio
del diametro di
6 mm. All’interno dell’intercapedine del controsoffitto è presente
uno “spazio di luce” alto 2 m, nel quale la luce artificiale di speciali
lampade a pendolo si rende complementare alla luce naturale.
Riferimenti bibliografici
- Heinz W. Krewinkel, Glass Buildings. Material, structure and
detail. Birkhauser, Basel, 1998, pp. 110-115.
- Peter Zumthor, Pensare architettura, Electa, Milano, 1998.
- Peter Zumthor, Kunsthaus Bregenz, aka Werkdokumente, Hatje,
1999.
- Peter Zumthor, “Museo de arte en Bregenz” in El Croquis n° 88-89,
pp. 288–292.
- Friedrich Achleitner, “Maison des arts” in AMC n° 84 pp. 32-41.
- Francois Burckhardt, “Museo d’arte, Bregenz, Austria” in Domus
n° 798 pp. 36-43.
- “L’avventura della visibilità. Kunsthaus, Bregenz (Austria), Peter
Zumthor” in Rassegna n° 86, pp. 58-67
- “Mystical presence” in The architectural review, 1210,
1997, pp.50-57
Disegni
Sezione
controsoffitto
Sezione
orizzontale
Sezione
sistema di attacco
Sezione
verticale 1:50
|